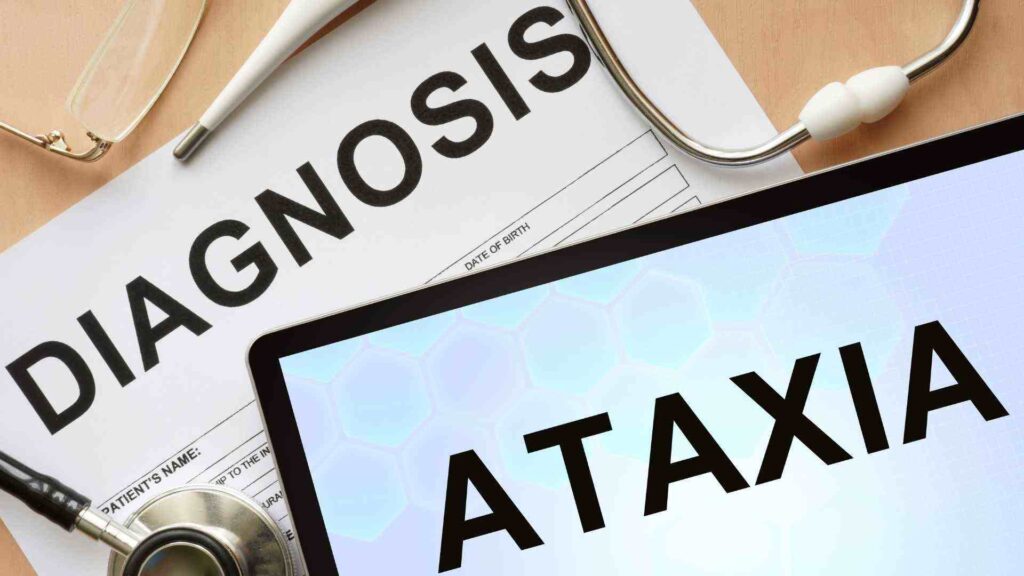Malattie neurodegenerative: l'Atassia di Friedreich:
Parlare di malattie neurologiche degenerative apre un campo ampio, ma l’atassia di Friedreich vanta una vasta letteratura clinica. Il primo a descriverlo fu Nikolaus Friedreich, un patologo e neurologo tedesco che ne scrisse nel 1863 mentre lavorava all’Università di Heidelberg. All’epoca la definì però come atrofia degenerativa dei cordoni dorsali spinali.
La denominazione attuale, atassi, deriva dal greco e significa letteralmente “senza ordine”, in riferimento agli spasmi incontrollati che provoca. Di natura genetica, si trasmette per via autosomica recessiva e colpisce una persona su 50.000, anche se in Europa l’insorgenza risulta di gran lunga maggiore. Si riscontrano circa 5 casi ogni 10.000 persone.
Comparsa e sintomi dell’atassia di Friedreich
Pur trattandosi di una patologia di origine genetica questa condizione rimane silente per i primi anni di vita. Il quadro clinico emerge verso la fine dell’infanzia o durante l’adolescenza, per la precisione nella fascia di età compresa fra i 10 e 15 anni. In alcuni casi però può manifestarsi molto prima, intorno ai 2 anni di vita, e purtroppo i casi precoci si associano a un decorso clinico più grave.
I sintomi della malattia possono essere eterogenei per gravità e tipologia nei pazienti. Si nota però che a livello generale si presentano problemi al senso dell’equilibrio e al controllo dei movimenti. Non è raro che i pazienti inizino ad avere difficoltà a mantenere una determinata postura per periodi prolungati, in particolare se in posizione eretta.
L’atassia di Friedreich si aggrava con il tempo, tanto che un po’ alla volta chi ne è affetto perde la capacità anche di svolgere semplici azioni quotidiane. Vale a dire vestirsi, mangiare e camminare, al punto che di frequente a distanza di 10-15 anni dalla diagnosi i pazienti sono costretti sulla sedia a rotelle. Nei casi più gravi la malattia causa cardiopatie dove il muscolo cardiaco si ingrossa a livello del setto ventricolare.
Agli esordi si può notare un’andatura incerta e una certa rigidità dei muscoli nel compiere le azioni, oltre a una certa difficoltà nell’articolare le sillabe quando si parla. Anche i riflessi via via si fanno più lenti fino a quasi scomparire del tutto, si fa fatica a deglutire e un po’ alla volta si finisce con il perdere il senso della vista e dell’udito.
La trasmissione della malattia
Abbiamo già premesso che l’atassia di Friedreich è una patologia genetica a trasmissione autosomico-recessiva. Questo significa che occorre presentare la mutazione su entrambi i cromosomi parentali, e si può essere portatori sani senza sospettare nulla. Se entrambi i genitori risultano portatori sani c’è un 25% di probabilità di avere un figlio malato, la stessa di averne uno sano (non portatore).
La sequenza genetica responsabile della malattia si trova su cromosoma numero 9 nella regione 9q13-q21 e si chiama FXN. La sua funzione è codificare per la frataxina, una proteina espressa a livello mitocondriale . Tra le sue funzioni ci sono la protezione della cellula dal processo ossidativo eliminando le sostanze di scarto prodotte dai mitocondri e la regolazione dell’utilizzo del ferro.
La sequenza nucleotidica che codifica per la frataxina presenta ripetizioni della tripletta GAA (guanina – adenina -adenina). Chi soffre di atassia di Friedreich però mostra a livello del cromosoma un’espansione instabile di questa tripletta. In una persona sana questa si presenta per un numero compreso fra le 7 e le 22 volte in questa regione cromosomica, ma nei malati se ne possono trovare più di 300.
Questa ripetizione porta a una riduzione della produzione di frataxina funzionale. Per comprendere se si risulti o meno portatori sani della mutazione di FXN è possibile effettuare un test genetico specifico elaborato per la prima volta nel 1996. Oggi l’accesso a questa analisi non è difficile come in passato e sempre più persone fanno domanda per svolgerlo.
Come diagnosticare l’atassia di Freidreich
In caso i genitori ignorino il fatto di essere portatori sani non è così facile formulare una diagnosi precoce per questa malattia. Tuttavia di fronte ai sintomi elencati nel primo paragrafo conviene rivolgersi a un neurologo per gli opportuni accertamenti. La valutazione comprende una visita preliminare seguita da un’analisi del sangue e una Magnetic Resonance Imaging (MRI) e al midollo spinale.
Durante la prima visita il neurologo cerca la presenza di difficoltà di equilibrio, perdita della sensibilità articolare e scarsi riflessi. Quando sono presenti si può procedere con test diagnostici più approfonditi come quelli elencati.
Con la MRI è possibile escludere altri disturbi neurologici che possono dare sintomi simili all’atassia di Freidreich. In più questo esame consente di evidenziare eventuali anomalie leggere nella regione del cervelletto che si possono ricollegare a questa patologia. Come test diagnostici aggiuntivi si prevedono di solito un’elettromiografia (EMG) e un ecocardiogramma.
La prima ha la funzione di misurare l’attività elettrica dei muscoli per capire la portata dei danni riportati dai nervi, mentre il secondo a capire sia presente una cardiopatia. Dispnea e palpitazioni sono sintomi comune nei malati a causa della perdita di forza da parte del tessuto del miocardio. Altra condizione associate sono il diabete e il piede cavo, ovvero arco plantare più alto del normale.
L’analisi del sangue serve proprio allo scopo di rilevare valori elevati di glicemia (correlati al diabete) o di vitamina E, collegata alla presenza del disturbo.