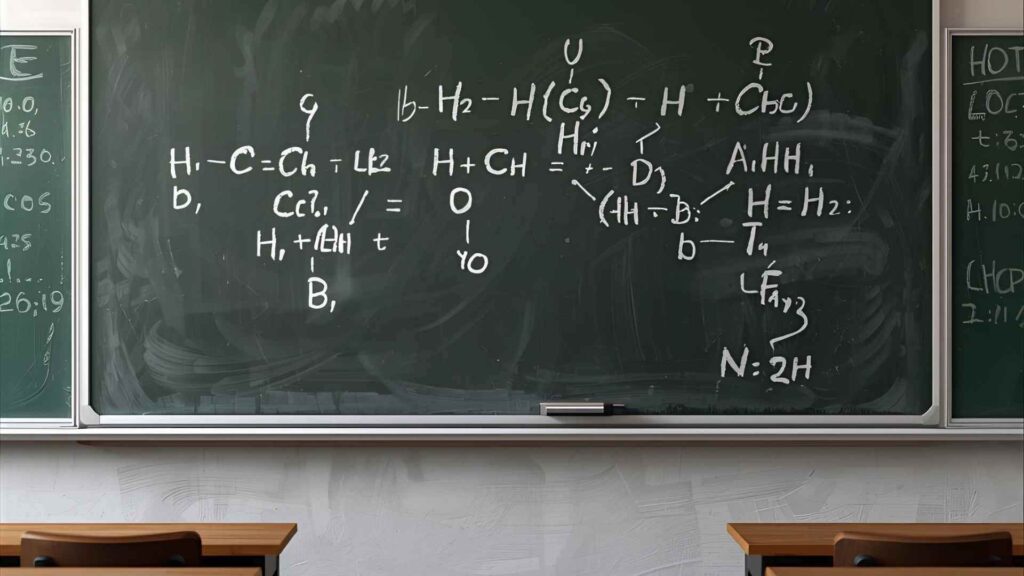Struttura e proprietà Immine o basi di Shiff
Quando parliamo di immine o di basi di Shiff nella maggior parte dei casi ci stiamo riferendo alla stessa classe di composti organici. Derivano dalla reazione di condensazione fra un’ammina primaria e un composto che contiene un gruppo carbonilico, ossia aldeidi o chetoni. Il gruppo carbonilico nel corso della reazione si distacca e a sostituirlo c’è il gruppo imminico, che contiene un atomo di azoto (N).
A coniare il nome di questi composti con il gruppo >C=N fu il chimico tedesco Albert Ladenburg nel 1883. Per questa denominazione prese il termine “ammina” e lo modificò leggermente. Una sottoclasse di questi composti costituisce le basi di Shiff, che invece furono battezzate da Ugo Shiff, chimico di origine tedesca successivamente naturalizzato in Italia.
La reazione per la sintesi delle immine
Per ottenere questi composti organici, di per sé non molto stabili come accennato servono un’aldeide o un chetone e un’ammina primaria, o in alternativa ammoniaca (NH3). In caso a reagire sia un’aldeide si ottiene come prodotto un’aldoimmina, mentre quando come reagente abbiamo un chetone si ricava una chetoimmina. La reazione di sintesi avviene in più stadi, quattro in tutto.
Nel primo passaggio interviene come catalizzatore acido lo ione H3O+, fornito dall’ambiente a pH acido necessario perché la condensazione proceda. Lo ione permette la protonazione dell’atomo di ossigeno presente nel gruppo funzionale dell’aldeide o del chetone. Il carbonio dl gruppo carbonilico si rende così disponibile per l’attacco nucleofilo da parte dell’atomo di azoto dell’ammina.
Il secondo stadio della reazione di sintesi delle immine consiste proprio in questo attacco nucleofilo. Da questo deriva un intermedio di reazione definito carbinolammina, che sancisce il terzo stadio del processo. Nel quarto e ultimo stadio della condensazione si ha la disidratazione della carbinolammina che elimina una molecola d’acqua (H2O) e si ottiene così l’immina.
Anche le basi di Shiff si ricavano dalla stessa reazione ma volendo si possono sintetizzare secondo una via alternativa. Questa prevede la deidrogenazione di un’ammina primaria ottenuta utilizzando composti inorganici ossidanti come l’acido cromico (H2CrO4) oppure il permanganato di potassio (KMnO4). Sempre le basi di Shiff si chiamano anche azometine.
Le regole per la nomenclatura
Possiamo distinguere le immine nelle due categorie già nominate sopra. Le aldoimmine hanno come formula generale R-CH=NH e possono essere sia primarie che secondarie, caso in cui essendoci due catene carboniose la forma generica diventa R-CH=N-R’. La formula delle aldoimmine secondarie è la stessa delle basi di Shiff, e infatti le due strutture coincidono.
Per quanto riguarda invece le chetoimmine, la formula generale di quelle primarie è RR’C=N-H, mentre per quelle secondarie è RR’C=N-R’’. Sia per le adoimmine che per le chetoimmine primarie la nomenclatura richiede per prima cosa di individuare la catena carboniosa più lunga. Una regola che vale per tutti i composti organici, non solo per le immine.
Una volta trovata la catena e contato il numero dei carboni si aggiunge il suffisso apposito, ovvero -immina. Per esempio considerando la molecola CH3(CH2)4NH si ha una pentanammina. Nel nome non è necessario specificare se derivi o meno da un’aldeide o da un chetone. Per quanto riguarda invece le strutture secondarie bisogna indicare il nome della catena secondaria legata all’azoto.
Per fare un esempio possiamo prendere la molecola CH3CH3-CH=NCH3, che ha legate all’azoto da una parte una catena con tre carboni e dall’altra un gruppo metile. La si chiama perciò N-metil-propanammina, facendo precedere nella definizione il nome della catena carboniosa più corta.
Le reazioni delle immine
Anche nel corso della reazione di Eschweiler-Clarke si forma questa molecola come intermedi di reazione. Questo processo consiste nella una metilazione di un’ammina primaria sfruttando la presenza di formaldeide e di acido formico (CH2O2). Con la metilazione ad opera della formaldeide si produce l’immina, dopodiché l’acido formico la riduce producendo un’ammina secondaria, Con lo ione idruro e in presenza di CO2 si ottiene infine un’ammina terziaria.
In ambiente acido le immine tendono infatti a ridursi e a formare un’ammina e un composto carbonilico. Per questo si sfruttano come materiale di partenza per sintetizzare sia le ammine primarie che quelle secondarie o terziarie. Le basi di Shiff producono ammine secondarie sia attraverso la riduzione catalitica che reagendo con i reattivi di Grignard. A contatto con gli alcali invece questo tipi di immina si presenta stabile
Queste particolari molecole hanno formula generica RMgX e si formano quando un alogenuro alchilico viene a contatto con il magnesio (Mg) in presenza di estere. La lettera X rappresenta un alogeno qualsiasi fra cloro, iodio, fluoro, bromo e astato, anche se quest’ultimo si trova di rado.