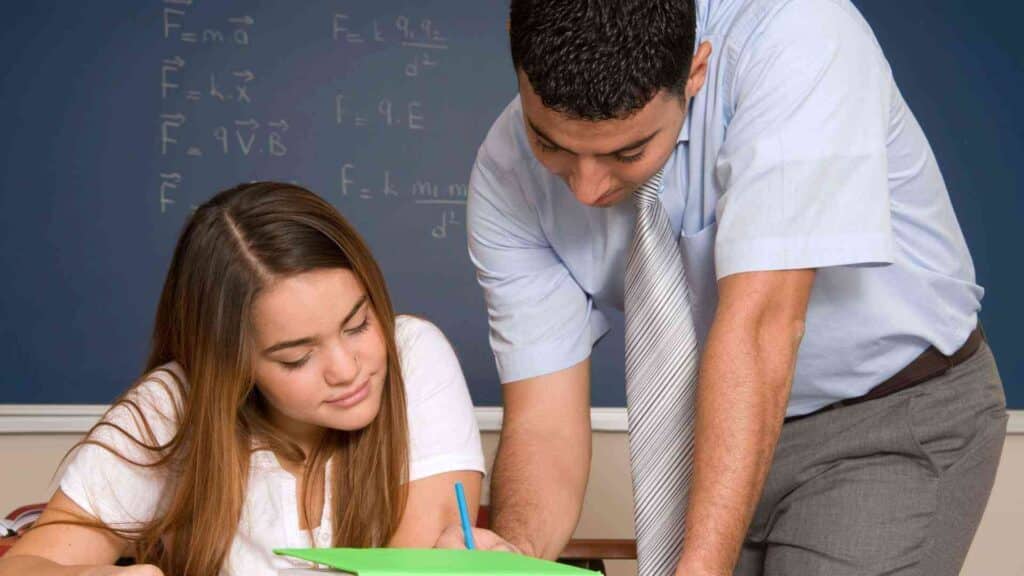Docimologia: i metodi per una valutazione equa
La docimologia, sebbene ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata, è fondamentale per studiare, analizzare e migliorare i metodi con cui si valuta l’apprendimento. Viviamo in un’epoca in cui la qualità dell’istruzione è costantemente sotto osservazione. Allo stesso modo, anche la valutazione degli apprendimenti ha acquisito enorme importanza. Ma come si può essere certi che un allievo abbia davvero imparato? E come rendere affidabile un giudizio espresso da un docente? È proprio per rispondere a queste domande che la docimologia viene in aiuto. In questa guida la approfondiremo in dettaglio.
Docimologia, significato e definizione
Iniziamo col chiarire gli aspetti fondamentali della docimologia: significato e definizione.
Possiamo intenderla come la disciplina che studia le modalità, le condizioni e gli strumenti con cui si valuta l’apprendimento degli studenti. Ma dietro questa definizione si nasconde un campo di ricerca vastissimo, in cui sono implicate diverse scienze, quali psicologia, statistica, didattica e sociologia.
Questa “scienza della valutazione” è nata agli inizi del Novecento, e ha portato alla luce un dato semplice, ma fondamentale: la valutazione scolastica è spesso soggettiva, imprecisa, e spesso addirittura ingiusta.
La docimologia opera in due ambiti: da un lato abbiamo quello descrittivo, che analizza come funziona realmente la valutazione. Questo aspetto considera anche le sue imperfezioni.
Da lato normativo, invece, ovvero propone metodi per migliorare l’attribuzione dei voti.
La nascita della scienza della valutazione
La docimologia nasce ufficialmente all’inizio del XX secolo, ma le sue radici affondano molto prima. Già nei secoli precedenti, filosofi e pedagogisti avevano sollevato dubbi sulla validità delle pratiche valutative scolastiche. Tuttavia, è solo con il contributo del prof. Henri Piéron che la docimologia diventa ufficialmente una disciplina scientifica autonoma.
Piéron, psicologo francese, coniò il termine docimologie, dal greco dokimazo, ossia esaminare, per indicare uno studio oggettivo e rigoroso dei processi valutativi, basato su dati misurabili, osservazioni sperimentali e metodi statistici. Il suo lavoro pionieristico mise in evidenza un aspetto fondamentale da considerare: la grande variabilità dei giudizi scolastici.
Attraverso studi condotti su prove scritte a opera di alcuni studenti, Piéron dimostrò che lo stesso elaborato poteva ricevere voti molto diversi a seconda del correttore. Queste variazioni non erano dovute a differenze nel merito, ma a fattori soggettivi come la severità, l’umore del docente, la sua formazione o persino la calligrafia dell’alunno. Nasce così il concetto di errore docimologico, ossia la differenza tra la prestazione reale dello studente e il giudizio assegnato.
Docimologia e valutazione scolastica
Uno dei concetti chiave della docimologia, quindi, è che non esiste valutazione priva di errore.
Esistono, però, dei modi per contenere e controllare l’errore: bisogna applicare criteri rigorosi e strumenti adeguati.
Per questo motivo, questo genere di studi si avvale di strumenti statistici per analizzare la coerenza, la validità e l’affidabilità delle prove. La docimologia, inoltre, analizza i comportamenti valutativi dei docenti, per capire in che modo giudizi personali, stereotipi e pregiudizi possono influenzare le votazioni.
Detto altrimenti, la docimologia non mira solo a migliorare le misurazioni, ma anche a valutare in modo più giusto e formativo.
In base a quanto detto fino ad ora, il rapporto tra docimologia e valutazione scolastica appare strettissimo. Possiamo dire che l’interesse principale della docimologia è proprio quello di rendere la valutazione scolastica più equa, coerente e costruttiva.
Bisogna considerare che, ad oggi, le valutazioni degli apprendimenti funzionano in modo disomogeneo. È per questo che due docenti diversi, ma che lavorano in uno stesso istituto, possono dare voti in modi molto differenti tra loro.
Le valutazioni date agli studenti dipendono infatti da moltissime variabili:
- differenze nella percezione della “difficoltà” del compito
- diversa tolleranza agli errori
- influenza del comportamento dello studente.
A questi aspetti si aggiungono anche i cosiddetti bias valutativi, ossia distorsioni che alterano il giudizio dell’insegnante.
Ed è qui che entra in gioco la docimologia, che analizza questi meccanismi e propone strategie per arginarli ed eliminarli.
Inoltre, pone l’accento anche sull’importanza della trasparenza nella valutazione, del feedback agli studenti e del coinvolgimento degli alunni.
Metodi e tecniche di valutazione
La docimologia non è solo una teoria critica: è una scienza sperimentale, che si basa su metodi rigorosi. I principali approcci adottati sono tre:
- osservazione sistematica, che consiste nell’osservare comportamenti valutativi reali, in contesti scolastici autentici. Si studiano, in dettaglio, modalità di correzione, differenze tra docenti, reazioni degli studenti, impatto emotivo del voto. L’obiettivo è raccogliere dati concreti, per analizzare quanto i giudizi siano coerenti, equi, motivati
- misurazione statistica, in cui la valutazione viene trattata come una variabile misurabile. Si applicano tecniche statistiche per calcolare medie e deviazioni standard, verificare l’affidabilità di una prova, valutare la validità, costruire indici docimologici. Si tratta di un approccio è molto usato nei test standardizzati e nelle ricerche accademiche
- analisi critica delle prove, che prevede una riflessione qualitativa, che analizza la costruzione, la chiarezza e le eventuali ambiguità dei quesiti. Ci si domanda, inoltre, se rispettano gli obiettivi didattici.
Strumenti utilizzati
L’influenza della docimologia sulla scuola è stata rilevante, soprattutto nel momento in cui si è cominciato a riconoscere che la valutazione non è un semplice atto finale o un giudizio statico, ma è una parte integrante del processo educativo.
La valutazione, infatti, non va intesa solamente come il momento conclusivo dell’attività didattica, ma deve essere inserita in una più ampia prospettiva didattica.
Il momento del voto non è più concepito come uno strumento di selezione o punizione. Deve diventare un momento di comprensione dei bisogni educativi degli studenti, utile alla pianificazione dell’insegnamento.
Già a partire dagli Anni Sessanta, in effetti, dalla misurazione oggettiva siamo passati a una prospettiva pedagogica della valutazione. È stato, cioè, riconosciuto il valore educativo della valutazione.
Un valore che passa per l’adozione di strumenti necessari per valutare adeguatamente gli apprendimenti.
Il passaggio fondamentale è stato quello dalla valutazione sommativa a quella formativa. In altre parole, non si valuta più solo per dare un voto, ma per accompagnare l’apprendimento, fornire feedback e orientare la didattica successiva.
Per garantire un voto equo, sono nati grazie alla docimologia, degli strumenti utili come:
- griglie di correzione oggettive
- rubriche valutative
- valutazione tra pari
- autovalutazione dello studente.
Avvalersi di questi strumenti e applicando i metodi della Docimologia, valutare in modo corretto diventa più semplice.