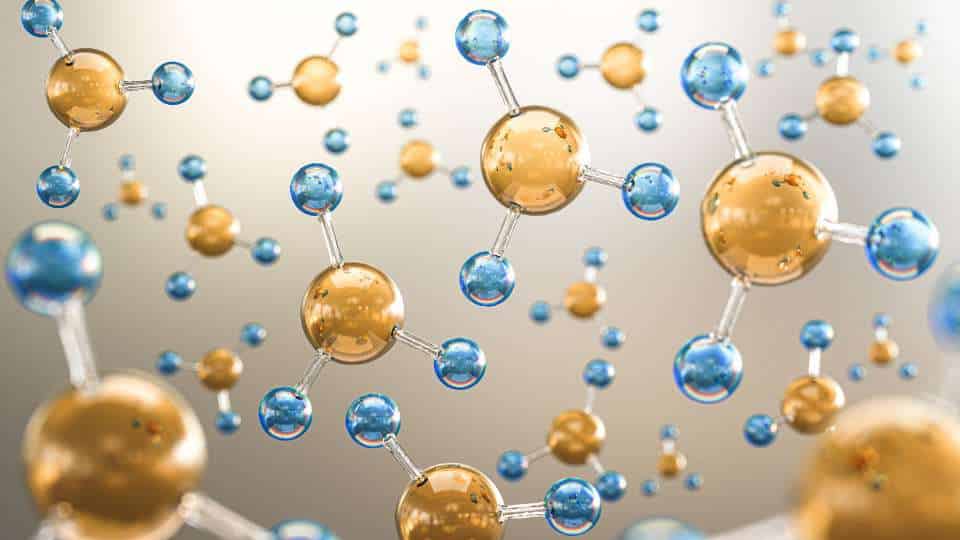Metabolismo e via dei pentoso fosfati
Quando parliamo di metabolismo pensiamo subito a glicolisi e ciclo di Krebs, dimenticando la via dei pentoso fosfati. Si tratta di un processo biochimico che prende il nome dal fatto che prevede la formazione di zuccheri a cinque atomi di carbonio, che definiamo appunto pentosi. Possiamo trovarla indicata anche come via del fosfogluconato o shut dei pentosi.
La collocazione spaziale di questo processo metabolico è all’interno del citosol delle cellule. Tuttavia risulta molto attivo in determinati organi e tessuti del corpo, tra cui il fegato, il tessuto adiposo, la tiroide e il tessuto muscolare. Nel tessuto muscolare invece è difficile registrarlo in quanto la via metabolica dominante è quella della glicolisi.
Le funzioni della via dei pentoso fosfati
Questo processo si dirama a partire dalla glicolisi e richiede la presenza di glucosio-6-fosfato (G6P) come substrato di partenza. Non possiamo classificarla come via energetica perché il suo scopo principale non è la produzione di ATP ma di NADPH (nicotinammide adenina dinucleotide fosfato). Inoltre prevede la decarbossilazione del G6P per formare i pentosi fosfati.
Questi zuccheri a cinque atomi di carbonio sono necessari alle cellule per la sintesi degli acidi nucleici, ovvero DNA ed RNA. I nucleotidi infatti sono composti da una base azotata, un gruppo fosfato e un monosaccaride pentoso: ribosio per l’RNA e desossiribosio per il DNA. Per quanto riguarda il secondo prodotto della via dei pentoso fosfati, l’NADPH, è un agente riducente fondamentale per alcuni processi biosintetici.
Si tratta infatti del substrato della glutatione reduttasi, l’enzima che rigenera il glutatione (GSH), un antiossidante cellulare abbondante negli eritrociti. Grazie alla sua capacità di cedere l’idrogeno presente nella sua molecola può contrastare l’azione dei radicali liberi dell’ossigeno. Una cellula sana di solito ha un rapporto di 9:1 fra le molecole di glutatione ridotto e ossidato.
Nei globuli rossi la presenza di NADPH e glutatione consentono di mantenere il ferro dell’emoglobina nel suo stato ridotto (Fe2+) impedendo che passi allo stato Fe3+. Questo metallo infatti è in grado di legare in modo efficace l’ossigeno e cederlo ai tessuti solo quando si trova nella forma ridotta. Diversamente si rischia una condizione di ipossia.
Le due fasi del processo
Una volta determinato il fine della via dei pentoso fosfati è ora di vedere quali sono i passaggi enzimatici che la caratterizzano. Possiamo dividerla in due sottoprocessi: la fase ossidativa e la fase delle interconversioni.
Solo durante la prima vediamo delle reazioni non reversibili, dove avviene già la formazione di NADPH e fosfopentosi.
Individuiamo tre passaggi in questa prima fase, partendo dalla ossidazione del G6P, che produce una molecola di NADPH e il 6-fosfoglucolattone. La quantità di NADPH prodotta funge da regolatore allosterico e dunque la reazione si autolimita. Vediamo poi l’idrolisi del 6-fosfoglucolattone in 6-fosfogluconato e una decarbossilazione per arrivare al ribulosio-5-fosfato (Ru5P).
L’Ru5P rappresenta il precursore di molte molecole biologiche e nella seconda fase della via dei pentoso fosfati subisce delle reazioni di isomerizzazione. Parte di esso diventa xilulosio-5-fosfato e parte invece ribosio-5-fosfato. Con reazioni successive fra questi due intermedi catalizzate dalla transchetolasi e dalla transaldolasi arriviamo ad avere fruttosio-6-fosfato e gliceraldeide-3-fosfato.
Possiamo ora stilare il bilancio di questa via scrivendola nella forma 6 G6P + 12 NADP+ + 7 H2O => 6 CO2+ 12NADPH + Pi. Il motivo per cui nel fegato e nel tessuto adiposo il processo è molto attivo è che l’NADPH interviene anche nei processi di sintesi del colesterolo e degli acidi grassi.
Via dei pentoso fosfati e glicolisi
Se in quel momento c’è necessità di energia e di ATP il G6P proseguirà lungo la glicolisi e il ciclo dell’acido citrico. Qualora ci fosse necessità di produrre ribosio invece si attiverà la via dei pentoso fosfati. Questa si può anche interrompere nel momento in cui si produce l’Ru5P, senza portare a termine anche la fase delle interconversioni.
Quando il ribosio 5-fosfato prodotto durante la seconda fase del processo è in eccesso è sempre possibile convertirlo in composti intermedi della glicolisi. Anche il fruttosio-6-fosfato e la gliceraldeide-3-fosfato sono molecole organiche che si formano durante la glicolisi, e dalla via che stiamo esaminando possono entrarvi facilmente.
All’interno dello stesso organo o tessuto l’ingresso del glucosio nella via alternativa della glicolisi aumenta in caso ci sia carenza di ossigeno. Questo perché non è possibile procedere con il ciclo di Krebs e si accumulano gli intermedi glicolitici all’interno della cellula. L’accumulo di ATP è un altro regolatore importante nel determinare il destino del glucosio-6-fosfato.