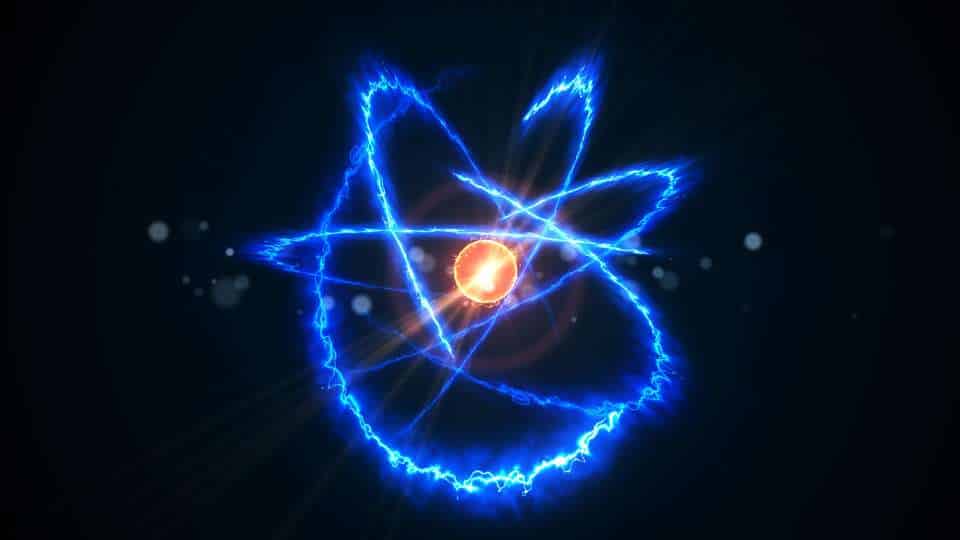La teoria atomica di Dalton, la terza legge fondamentale della Chimica
Nella storia della Chimica un anno fondamentale è il 1808, anno in cui vide la luce la teoria atomica di Dalton. Questo modello di rappresentazione dell’atomo prende il nome da John Dalton, chimico e fisico inglese. In giovane età si dedicò allo studio della meteorologia e dei fenomeni atmosferici, dopodiché si interessò allo studio delle caratteristiche dei gas.
A questo studioso si deve dunque quella che è considerata la terza legge fondamentale della Chimica. Le prime due sono attribuite rispettivamente a Antoine Lavoisier (legge di conservazione della massa) e a Joseph Proust (legge delle proporzioni definite). Insieme le si raggruppa anche sotto la definizione di leggi ponderali, fondamentali per lo studio delle reazioni chimiche.
Cosa afferma la teoria atomica di Dalton
Quanto enunciato dal chimico inglese nel 1808 non si basava solo sulle sue assunzioni ma si basava anche sulle altre due leggi accennate, quella di Lavoisier e quella di Proust. Si trattò della prima interpretazione della materia in termini atomico-molecolari, e pur se con diverse inesattezze e incompleta gettò le basi per i modelli atomici sviluppati successivamente.
I principi su cui si basa sono più di uno, ma quello fondamentale è il fatto che la materia sia composta da particelle microscopiche. Parliamo degli atomi, considerati da questo scienziato come indivisibili e inalterabili. Già qui vediamo degli errori nella teoria atomica di Dalton, dato che sappiamo che è possibile spezzare un atomo e che esistono particelle subatomiche: elettroni, neutroni e protoni.
La teoria afferma poi che gli atomi di uno stesso elemento chimico, come l’oro (Au) o l’argento (Ag) siano tutti dotati della stessa struttura e delle stesse proprietà. Di conseguenza invece i diversi elementi sono composti tutti da particelle diverse fra loro, che non possono essere convertiti gli uni negli altri. Atomi diversi possono però combinarsi fra loro per produrre composti molecolari.
Su quest’ultimo punto occorre precisare che solo atomi interi possono formare legami, non frazioni di essi. Inoltre per ottenere delle molecole è necessario che gli elementi reagiscano fra di loro secondo rapporti ben definiti e costanti. Anche tali rapporti si definiscono solo con numeri interi, non con frazioni.
L’evoluzione del modello dell’atomo fino a Thomson
Oltre alla teoria atomica di Dalton sui libri di Chimica troviamo ampio spazio dedicato a quello che fu il modello di atomo che riuscì a elaborare dalle sue conoscenze. Al suo tempo non era ancora nota l’esistenza né dei protoni né degli elettroni, così come il concetto di carica atomica o di ione. Perciò per questo studioso l’atomo risultava una particella unica, compatta e neutra.
Dalton li rappresenta infatti come sfere, che nel caso di uno stesso elementi sono uguali per grandezza e colore. Il concetto di atomo indivisibile risaliva ancora a un’idea avuta dal filosofo greco Democrito, uno dei fondatori dell’atomismo. Tale pensiero fu poi ripreso da Aristotele, che affermò che la materia si potesse dividere in particelle sempre più piccole, fino a una che sarebbe risultata indivisibile.
Alla fine del 1800, per la precisione nel 1897. anche J.J. Thomson elaborò una struttura atomica più complessa di quella definita dalla teoria atomica di Dalton. Questa teneva conto delle cariche interne all’atomo. Si mantenne una forma sferica, ma l’atomo risultava una distribuzione di carica positiva al cui interno si trovavano gli elettroni, particelle cariche negativamente.
Nella concezione di Thomson le due cariche (la sfera positiva e le particelle negative) erano in grado di annullarsi reciprocamente, facendo risultare l’atomo neutro. Per definire l’esistenza di un nucleo positivo e dello spazio vuoto tra esso e gli elettroni si sarebbe dovuto aspettare il modello di Rutherford, proposta nel 1911.
Gli errori principali della teoria atomica di Dalton
Abbiamo già fatto presente la mancanza principale di questo modello di atomo, ovvero la mancanza del concetto di particella subatomica. Oltre a questo però ci sono diverse precisazioni da fare che sono necessarie per comprendere la natura molecolare della materia. Per Dalton ad esempio gli atomi potevano esistere in forma individuale, escludendo però così le molecole biatomiche.
Per fare alcuni esempi abbiamo l’azoto o l’ossigeno molecolare (N2, O2), o le forme molecolari degli alogeni come il fluoro (F2) e il cloro (Cl2). Non concepire queste combinazioni fra gli atomi gli impedì anche di ipotizzare molecole come l’acqua (H2O) credendo invece che la sua formula fosse HO. Nella teoria atomica di Dalton si ipotizzava infatti che il rapporto più comune fra due elementi fosse un atomo di ciascuno.
Anche il principio secondo cui gli atomi di un elemento chimico fossero immutabili non risulta confermato. Ci sono infatti atomi che possono cambiare la propria struttura come si osserva nei fenomeni di decadimento radioattivo. Il plutonio per esempio può decadere dal suo isotopo 244Pu fino a diventare un isotopo dell’uranio, per la precisione 240U.
Un altro esempio è il curio (Cm), che può decadere da 244Cm fino a trasformarsi in un isotopo del plutonio (240Pu). I processi con cui può avvenire il decadimento radioattivo sono tre: il decadimento alfa, il beta e il gamma, che si differenziano per il tipo di particelle emesse dal nucleo radioattivo.
Il contributo dato ai calcoli stechiometrici
Sebbene presenti dei forti limiti dovuti all’arretratezza delle conoscenze e della strumentazione analitica dell’epoca, la teoria atomica di Dalton ebbe una discreta utilità. Insieme alle leggi di Lavoisier e di Proust infatti permise di sviluppare la stechiometria, ovvero lo studio dei rapporti quantitativi fra le sostanze nelle reazioni chimiche.
Per esprimere la stechiometria di una reazione si usano i coefficienti stechiometrici. Sono numeri interi scritti davanti ai simboli chimici degli elementi o delle molecole. Ogni coefficiente moltiplica gli indici, ovvero i numeri messi a pedice degli elementi, che indicano in che numero sono presenti nella molecola.