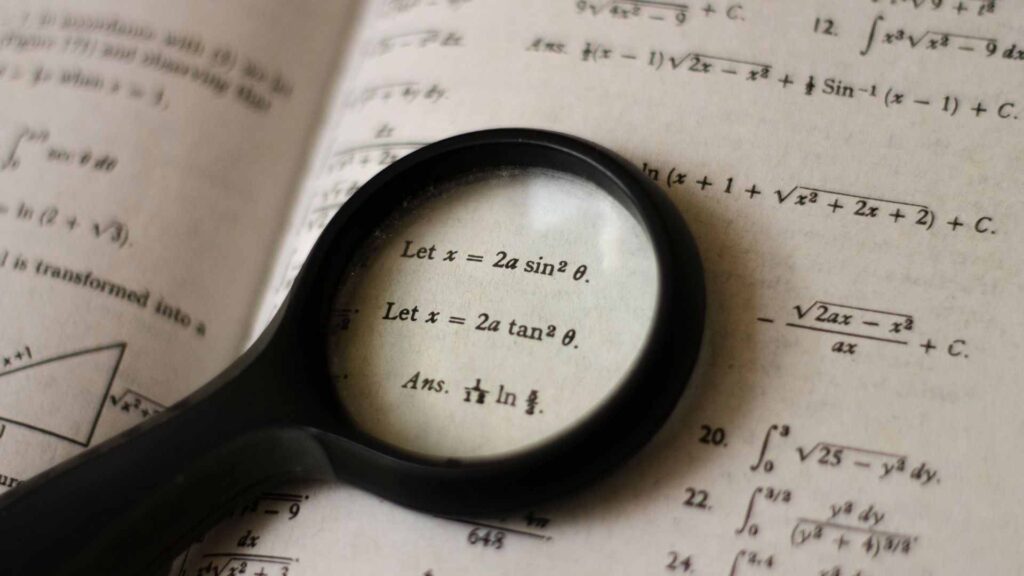Equazioni di Henderson- Hasselbalch: formule e applicazioni in chimica
Per determinare il pH di un acido o di una base debole la soluzione è usare l’equazione di Henderson-Hasselbach. Questi composti infatti non sono in grado di dissociarsi completamente in soluzione acquosa a differenza di quanto avviene per acidi e basi forti, che si ionizzano completamente. A elaborarla nel 1908 furono i due scienziati da cui prese il nome, il danese Hasselbalch e lo statunitense Henderson.
Questa equazione si può utilizzare per gli acidi deboli come l’acido acetico (CH3COOH) considerando la costante di dissociazione acida propria di ciascuno. Lo stesso vale per le basi deboli (es. NH3) per le quali si ricorre alla costante di dissociazione basica. In entrambi i casi la formula mostra l’effetto compensativo fra acido e base coniugata tipico delle soluzioni tampone.
L’equazione di Henderson-Hasselbalch: Ka e Kb
Per comprendere questo ambito è necessario partire dai concetti di costante di dissociazione acida (Ka) e basica (Kb), ma prima ancora di definire cosa sia la forza degli acidi e delle basi. Un acido debole e una base debole si idrolizzano parzialmente una volta in soluzione acquosa, e questa reazione è in equilibrio con la sua inversa, ossia quella che lo riforma.
Nel caso di un acido debole generico HA possiamo scrivere la reazione di ionizzazione nella forma HA <=> H+ + A-. In particolare A- rappresenta la base coniugata dell’acido, che ad esempio per l’acido acetico menzionato prima equivale a CH3COO-. Per le basi deboli invece possiamo indicare la forma generica con B e scrivere la reazione di ionizzazione con B + H2O <=> HB+ + OH-. BH+ rappresenta l’acido coniugato della base B.
Nell’equazione di Henderson–Hasselbalch troviamo anche la costante Ka per gli acidi deboli e le Kb per le basi deboli. Più un acido è debole più il valore della sua Ka risulterà esiguo, e lo stesso vale per le basi e la loro Kb. Per acidi e basi forti i valori di Ka e Kb si aggirano intorno a 1, come vale ad esempio per l’acido cloridrico o l’idrossido di sodio.
Il valore più basso che possiamo trovare per una Ka o una Kb è 10-14, ossia il valore che assegnato all’acqua per entrambe a temperatura ambiente. Dobbiamo precisare infatti che Ka e Kb variano a seconda della temperatura, ma di solito usiamo i valori corrispondenti a 25°C.
Calcolare il pH di un acido debole
Vediamo ora l’equazione di Henderson-Hasselbalch per un acido debole generico HA. Per trovare il pH di una soluzione in cui è presente HA la formula da usare è pH = pKa + log[A-]/[HA]. La pKa corrisponde al logaritmo della costante di dissociazione acida della sostanza considerata. Invece [A-] e [HA] rappresentano le concentrazioni della base coniugata e dell’acido di partenza, espresse in molarità.
Prendiamo ad esempio l’acido acetico (CH3COOH) che a 25°c presenta una Ka pari a 1,8 x 10-5. Supponiamo ora di avere una soluzione acquosa concentrata 0,1 M per l’acido e 0,4 per la base coniugata CH3COONa. Quale sarà il pH di questa soluzione? Avendo già le concentrazioni espresse in moli su litro ci serve solo calcolare il pKa per avere tutti i dati necessari.
Bisogna quindi fare il logaritmo di 1,8 x 10-5, ossia 4,7. A questo punto usiamo l’equazione di Henderson-Hasselbalch e sostituiamo i valori trovati. Quindi avremo che pH = 4,7 + log[0,4]/[0,1] = 5,3. Dato che la base coniugata risulta più concentrata dell’acido il pH si alza in quanto c’è un effetto tampone che riduce gli ioni H+ in soluzione.
Conoscendo il pH di una soluzione in cui è presente un acido debole e la concentrazione della base coniugato e dell’acido possiamo determinarne la Ka a temperature diverse da quella standard. Se svolgiamo una reazione di ionizzazione sotto i 25°c infatti avremo una Ka inferiore, mentre al di sopra di questa temperatura risulterà maggiore
Il calcolo del pH nel caso delle basi deboli
Come prima la pKb rappresenta il logaritmo della Kb della base, mentre i fattori fra parentesi quadre sono le concentrazioni molari dell’acido coniugato e della base. Prendiamo anche qui un caso pratico considerando l’ammoniaca (NH3), che a temperatura ambiente ha una Kb che vale 1.8 x 10-5. Supponiamo ora di avere una soluzione con NH3 concentrata allo 0.2 M e NH4Cl allo 0.25 M. Qual è il pH di tale soluzione?
Come nel caso precedente dobbiamo calcolare il pKb, quindi fare il logaritmo della Kb. Otteniamo 4,7 e a questo punto possiamo procedere nel calcolo del pOH con l’equazione di Henderson-Hasselbalch. Quindi sostituiamo i valori a disposizione e scriviamo pOH = 4,7 + log[0,25]/[0,2] = 4,79. Non abbiamo però ancora il valore del pH bensì del pOH, che misura la basicità di una soluzione.
Dato che di regola la somma fra pH e pOH è sempre uguale a 14 per ricavare il primo tutto ciò che ci serve è una sottrazione. Facciamo quindi 14 – 4,79 = 9,21.